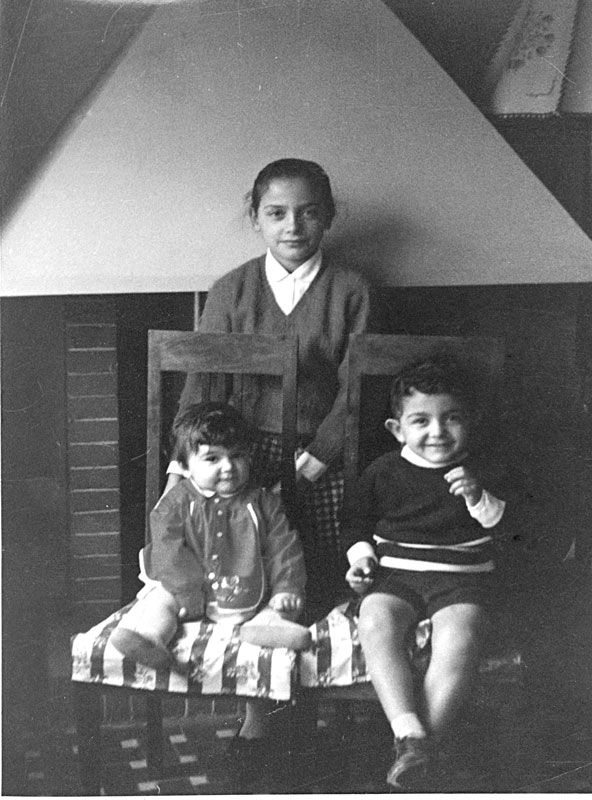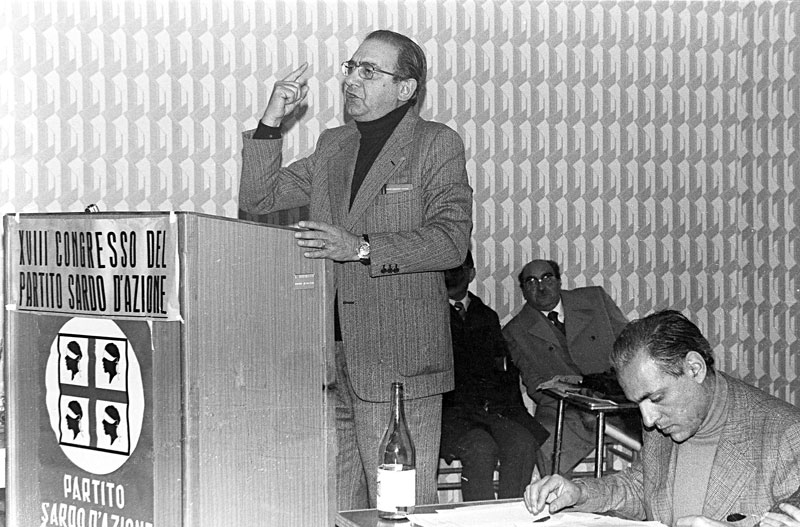La ricorrenza del cinquantenario della fondazione delle Nazioni Unite ci offre l’opportunità di serie riflessioni critiche sul ruolo svolto da questa Istituzione nel corso dell’arco di storia che ha visto mutare lo scenario politico mondiale nel realizzarsi di nuovi assetti ed equilibri fra gli stati.
Gli obiettivi all’origine del suo costituirsi sono sostanzialmente due, entrambi di valore universale: garantire la pace fra i popoli della terra e favorire l’affermarsi di regimi democratici in quegli stati ancora immersi nella notte delle dittature.
I risultati sotto i nostri occhi sono significativi ed ammonitori.
Pur avendo offerto una sede di mediazione e composizione di contrasti e conflitti fra gli stati e, talvolta, all’interno di questi, promuovendo, di volta in volta, il confronto e il dialogo, dobbiamo constatare che, mancando la volontà di una delle parti, i contrasti sono diventati scontri e quindi guerre atroci con sacrificio di vite umane e distruzione di preziose risorse.
Come non ricordare la guerra fra l’India e il Pakistan conclusa con la costituzione di un nuovo Stato, il Bangladech; l’annientamento dello Stato del Tibet e la sua annessione alla Cina; i sette anni di guerra fra Iran ed Irak per il controllo dello Schat el Arab e Bassora e quindi del petrolio del Golfo Persico; le angosciose lotte del popolo curdo che da millenni rivendica il diritto ad una patria, massacrato dagli eserciti di irakeni, turchi, iraniani e siriani; l’orrendo sterminio di cui siamo stati impotenti testimoni delle guerre tribali di Burundi e Ruanda; i genocidi nello Stato somalo e, trascurando altri drammatici esempi, la lotta ingaggiata dal popolo palestinese contro Israele da un lato, e a suo tempo, quella fratricida contro lo Stato giordano ( settembre nero).
L’attualità deve prendere atto della carneficina ancora in atto fra Serbi, Croati, Montenegrini, Albanesi, Macedoni e Bosniaci.
L’O.N.U. nonostante il prodigarsi dei suoi massimi esponenti nulla ha potuto per impedire o scongiurare tanto sfacelo di valori civili ed umani.
Ed è qui il punto politico; l’interrogativo del perché una Istituzione così prestigiosa, nella quale sono rappresentati – ed hanno diritto di parola e di voto – la stragrande maggioranza degli stati, ha fallito obiettivi che costituiscono la ragione stessa della sua esistenza.
La ragione è molto semplice: l’O.N.U., pur avendo soggettività e personalità giuridica, non ha i poteri necessari per assoggettare alle proprie decisioni gli stati che lo costituiscono.
Non dispone cioè di un requisito essenziale per esercitare il potere d’imperio: la sovranità.
L’O.N.U. non è infatti una federazione di stati ma più semplicemente un’associazione fra questi, priva perciò di poteri cogenti suscettibili d’imporre, con la forza, il rispetto delle sue decisioni.
Se oggi Palestinesi ed Israeliani, con il concorso di Egiziani e Giordani si avviano verso un traguardo di pace lo si deve alla determinazione degli Stati Uniti nell’imporre la “pax americana”; né da questa politica si discostano le trattative di pace in corso fra Serbi, Bosniaci e Croati visto che a rovesciare le sorti della guerra in atto ha concorso la politica internazionale del Presidente Clinton deciso ad intervenire con le forze armate americane per annientare la macchina da guerra serba.
Non l’O.N.U. quindi ma la politica dei singoli stati continua ad essere all’origine della guerra e della pace fra i popoli del mondo.
La stessa Comunità Europea, pur dipendente dal petrolio del Golfo Persico, sia per gli usi civili che industriali ed agricoli, nulla ha potuto per annullare il fatto compiuto posto in essere da Saddam Hussein nell’invadere e controllare militarmente l’area petrolifera del Kuwait.
Così un’altra grande, fascinosa illusione fa i conti con la storia.
Filosofi, illustri politici ma anche grandi correnti di pensiero che hanno attraversato la cultura e la mobilitazione politica del nostro Continente, hanno auspicato il costituirsi di una Federazione di Stati Europei che partendo dal Mercato Comune ne favorisse con l’integrazione il riequilibro politico-economico dando vita altresì ad una cittadinanza europea capace di superare le antiche frontiere militari ed i conflitti d’interesse per i quali sono state scatenate guerre che hanno coinvolto tutto il mondo civile.
La mancanza di sovranità riduce infatti la cosiddetta Unione Europea (così pomposamente qualificata nel Trattato di Maastricht) ad una associazione di stati nella quale, in difetto di unanimità, tutto si ferma.
Si ferma soprattutto la politica ed emerge il mercato; emergono cioè le forze economiche che proprio in virtù delle leggi di mercato determinano l’egemonia dei forti e contestualmente il progressivo spegnersi delle potenzialità dei deboli.
Gli stati, obbedendo alla naturale vocazione espansiva della forza, impongono o subiscono gli interessi internazionalmente prevalenti nel rispetto formale dei protocolli di Maastricht, che, tutto sommato, conducono agli stessi risultati delle politiche tradizionalmente praticate attraverso i canali diplomatici.
Certo, si è scongiurata la guerra fra gli stati Europei e si è pure realizzato un progresso diffuso in parte anche nelle aree del sottosviluppo mediterraneo; tuttavia a nessuno sfugge come il distacco socio-economico tra le aree forti e quelle deboli è pericolosamente aumentato; di talchè l’Europa si va disarticolando in compartimenti che marciano a velocità diverse nei diversi treni dello sviluppo.
La politica della Comunità è ormai diventata la politica delle forze che l’hanno egemonizzata per cui i “contingenti” produttivi e i “fondi strutturali” si muovono secondo logiche finalizzate a consolidare ed esaltare le economie forti a tutto danno di quelle deboli confinate in un ruolo di aree assistite cui si rimprovera incapacità di governo, clientelismo, rissosità e quant’altro segna a fuoco le carni dei corpi sociali stremati dall’emarginazione, dalla subalternità e dalla miseria.
E cadrebbero in una pericolosa illusione i popoli dell’Est Europa e del Nord Africa se ritenessero i trattai di commercio stipulati fra la Comunità Europea e i loro Paesi finalizzati all’obiettivo di esercitare nei loro confronti atti di concreta solidarietà.
La verità è che la Mitteleuropa compra prodotti agro alimentari nel Nord Africa, nei Paesi dell’est europeo o in Sud.America, solo in vista dei bassi prezzi dovuti al costo del lavoro particolarmente modesto. Le stesse motivazioni sono alla base degli insediamenti industriali (di norma limitati a prime lavorazioni o ai processi estrattivi) realizzati dagli Europei nel così detto Terzo Mondo.
Poiché nelle sacche del sottosviluppo europeo (Spagna, Portogallo, Sud Italia Grecia, etc.) i costi del lavoro e dei consumi sono ancorati ai parametri registrati nelle aree del pieno sviluppo dei rispettivi stati ne consegue la non competitività delle produzioni rispetto a quelle concorrenti dei paesi del Nord Africa, Est Europeo, Sud America e, in genere del Terzo Mondo, dai cui mercati si approvvigiona – specie per i comparti agro-alimentari – la Comunità Europea. Questa politica determina, a causa dello scompensato rapporto export-import, l’ulteriore indebitamento del sistema economico delle aree povere d’Europa nei confronti di quelle ricche.
Questo è in sostanza il nocciolo del problema.
Gli stati, gelosi difensori del loro potere d’imperio si organizzano, si legittimano e sostanzialmente si identificano con gli interessi che prevalgono al proprio interno; interessi che pur privilegiando ristrette fasce di potere coinvolgono, condizionano e mobilitano vaste masse popolari insediate, di norma,in aree ben definite nelle quali si consolida lo sviluppo economico-sociale e civile realizzato, in gran parte, a spese del sottosviluppo delle aree emarginate, ridotte così a serbatoio di manodopera e mercato di consumo di prodotti importati.
È facile capire come gli interessi forti trovino composizione ed alleanze internazionali mentre quelli deboli vengono sospinti, direi meccanicamente, in reciproco conflitto per spartirsi la benevola attenzione dei potenti ai quali basta la politica dell’assistenzialismo per consolidare il loro primato. Le realtà territoriali povere perdono così anche i residui spazi di autonomia politica delle rispettive istituzioni di governo.
La risposta a questo processo involutivo si concreta nel riprendere il cammino originariamente intuito dai grandi federalisti che, ormai da secoli, indicano nella sovranità esclusiva degli stati l’ostacolo più difficile al realizzarsi dei processi di integrazione e solidarietà fra i popoli dell’Europa e del Mondo.
Non a caso in questi ultimi cinquant’anni l’Europa ha visto fiorire due nuove realtà istituzionali: la Comunità Europea (che nasce dal desiderio dei popoli di dar vita ad una casa comune dove la forza dei suoi componenti diventa la forza della Comunità e la Comunità la forza di questi) e, contestualmente, all’interno dei singoli stati, la ricchezza di realtà territoriali ed umane, connotate da specificità peculiari nascenti da territorio, comunanza di interessi, esperienze storiche, tradizioni, usi, costumi, cultura e lingua, che li rende unici ed irripetibili. Realtà organizzate in istituzioni di governo dotate, generalmente, in concorso e non in contrasto con lo stato, di poteri legislativi in virtù dei quali organizzano la propria vita democratica e fissano gli obiettivi dello sviluppo, realizzati in forza di bilanci alimentati da risorse proprie e, ove occorra, dalla solidarietà dello stato.
Questo processo ha dato vita in Italia, Spagna,, Austria, Belgio, Germania e, in forme – e in limiti assai diversi, in Francia e Portogallo – ad un vasto movimento regionalista che in alcuni paesi ha assunto rilievo federale mentre in altri è rimasto nell’ambito di autonomie costituzionalmente garantite.
Questi i due pilastri della nuova democrazia europea; la Comunità da un lato, le Regioni dall’altro.
Dire “regioni” significa dire popoli; questi non sempre trovano però sufficienti spazi per affermare la loro soggettività politica all’interno dei rispettivi Stati.
Basti pensare a Baschi, Catalani, Andalusi, Galiziani e Canariensi in Spagna; a Baschi, Catalani, Bretoni, Occitani e Corsi in Francia; Gallesi, Scozzesi, Cornici ed Irlandesi in Gran Bretagna, ed altre minoranze e fra queste quelle presenti in Italia, per cogliere la pervicacia degli stati nel contrastare da un lato raffermarsi dell’Europa Unita e, dall’altro, il regionalismo europeo.
La ragione è sempre la stessa: mantenere sostanzialmente integra la propria sovranità cedendone parte irrilevante al potere sovranazionale ed ancor meno alle istituzioni regionali.
La via maestra è però un’altra.
Non possiamo avere all’interno della “casa comune” entità socio-territoriali fra loro fortemente squilibrate senza squilibrare la Comunità medesima
Le regioni debbono poter dialogare fra loro e con la Comunità senza bisogno di particolari autorizzazioni dei rispettivi stati, ottenendo così il significativo risultato di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita comunitaria attraverso le strutture democratiche di base: Regioni, Province e Comuni, sedi nelle quali far valere i propri diritti a tutti i livelli; si attenuano così sino a dissolversi i condizionamenti delle antiche egemonie formatesi attorno alle sedi verticistiche degli stati, costrette al confronto quotidiano con una sovranità diffusa che si realizza attraverso le regioni aventi pari dignità su tutto il territorio europeo.
Gli stati dovranno così evolvere il loro ruolo in forme nuove, sia nel vasto campo della promozione culturale che dei valori unificanti di solidarietà, di conoscenza, di progresso.
Sarà allora possibile a noi regioni mediterranee essere, oltre che il sud di Europa, anche i rivieraschi di un mare che ci chiama a rapporto di collaborazione ed integrazione feconda con paesi e popoli dai quali solo la politica dei nostri dominatori ci ha tenuti lontani e contrapposti.
Per me sardo, sottoposto per molti secoli di questo millennio alla colonizzazione economica, politica e culturale di catalani, spagnoli, piemontesi e genovesi, vi è piena coscienza di costituire minoranza etnica inglobata nello Stato italiano e di aver subito e subire una dura emarginazione che trae origine -fra l’altro – dalla stessa collocazione geografica della Sardegna.
I governi italiani l’hanno riguardata quale appendice staccata e lontana prigioniera del mare, penalizzata dai costi aggiuntivi del trasporto marittimo che rendono la sua economia non competitiva rispetto a quella nazionale.
Una visione centralistica che condanna la nostra diversità all’alienazione culturale, emarginazione economica e subalternità politico-istituzionale.
II tutto supportato e consolidato da una politica di assistenzialismo che umilia la dignità stessa dei cittadini ridotti, nei fatti, al rango di sudditi. Visione distorta che falsa e condiziona le prospettive dello sviluppo possibile.
In effetti la Sardegna non è affatto appendice marginale d’Italia o d’Europa, ma potenzialmente punto di forza dell’economia mediterranea in considerazione della sua centralità fra Europa sud-occidentale e nord Africa, momento di snodo ed incontro fra culture ed economie intercontinentali.
Potenzialità queste non gestibili dai vertici statali, di fatto non interessati a promuovere il ruolo internazionale dell’isola sarda peraltro mai proposto – in quasi sette secoli – da spagnoli, piemontesi, pisani o genovesi, né dallo Stato italiano . Ciò non solo per indifferenza, non conoscenza dei problemi, ma per contrasto d’interessi con realtà territoriali politicamente più forti ed influenti nel governo dello Stato.
Solo il potere istituzionale sardo può rivendicare a se questo compito . Un potere che si realizza, nella riforma federalista dello stato, dentro lo stato, nel riequilibro fra le varie articolazioni territoriali dello stato.
Una riforma che consentirà a noi sardi di riaprire il dialogo, interrotto da millenni, con i paesi rivieraschi del Mediterraneo e concorrere con loro ad un progresso che si apre su orizzonti di pace e solidarietà fra popoli non più divisi da frontiere militari, né oppressi da colonizzazioni prevaricanti, ma protagonisti tutti della civiltà del duemila.
Convegno di Studi Internazionali – “Il regionalismo internazionale mediterraneo nel 50° anniversario delle Nazioni Unite” – Cagliari, 6 -7 ottobre 1995 aula consiglio regionale
21 Febbraio 2017 by