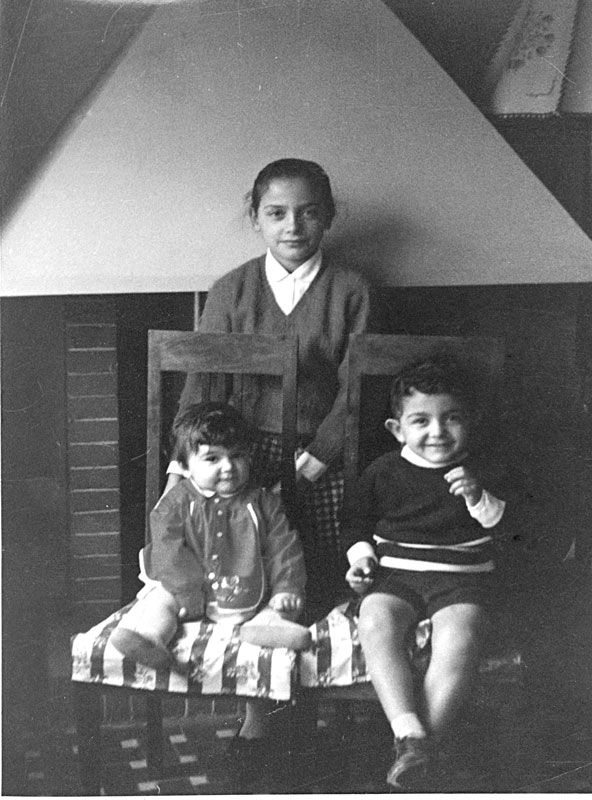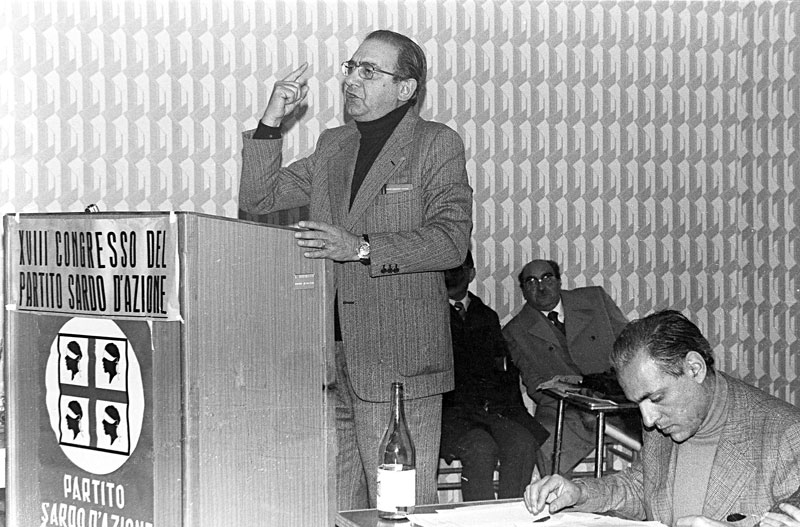L’autonomia patrimonio irrinunciabile, Consiglio regionale della Sardegna, Cagliari, 12 marzo 1987
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
io penso che questo dibattito abbia fatto emergere come elemento dominante un valore che ormai informa di sé l’intera vita regionale: l’autonomia. Un valore nel quale la società sarda si identifica, che la società sarda ha acquisito come patrimonio irrinunziabile, quale modo di essere del nostro popolo, espressione di una soggettività politica gelosamente difesa e quindi riaffermata non solo sul piano istituzionale, ma come diffusa aspirazione democratica, che nell’autonomia trova lo strumento naturale per esprimersi.
Autonomia che ha vissuto tutto il travaglio di un’evoluzione storica durata ormai quarant’anni, che ha subito l’impatto delle grandi trasformazioni che hanno cambiato il volto del mondo: si sono modificati i ritmi dell’economia, si sono modificati i consumi (non solo sul piano della quantità, ma soprattutto della diffusione e dell’estensione a vasti strati sociali che prima ne erano esclusi), si sono profondamente modificate le produzioni; i trasporti hanno, dagli anni 40 ad oggi, consentito processi di integrazione per l’innanzi impensabili, non solo tra le aree economiche, ma nei rapporti tra le grandi comunità; le comunicazioni di massa hanno trasferito modelli di civiltà e di vita dai centri di maggior forza e propulsione economica e civile agli altri in un processo di integrazione su scala planetaria. Nei nostri piccoli comuni si respira la civiltà economica o i problemi o i bisogni della società milanese o di quella americana, perché i mezzi di comunicazione di massa questo hanno determinato, stimolando esigenze e modelli di consumo non strettamente coerenti alle necessità primarie del popolo. Le tecnologie sono cambiate, rivoluzionando il nostro mondo; le stesse strutture sociali sono profondamente modificate. La Sardegna è cambiata: da un’economia agropastorale ed artigianale, perduta nelle nostalgie del passato e in una visione quasi omerica della società, caratterizzata da villaggi tra loro in difficile comunicazione, per mancanza di mezzi che ne facilitassero l’integrazione reciproca, oggi siamo passati ad un’economia caratterizzata da un terziario forse non avanzato ma certo molto diffuso, che prevale anche sull’attività industriale, accanto al quale coesiste, ma non più come elemento principale, la componente agropastorale.
Sì, è cambiata la Sardegna, profondamente; sono cambiati i suoi problemi, si sono modificate la sua struttura sociale e la sua cultura. È cresciuta nel contempo la consapevolezza di una soggettività politica che si realizza nell’autonomia — ecco l’elemento emergente, dominante, che informa di sé la nostra società — e si sono modificate le istituzioni. Il comune, da ente di amministrazione elementare, di pura registrazione dei movimenti anagrafici, è diventato soggetto politico di aggregazione e di propulsione democratica, di aggregazione e propulsione di interessi economici. Governo l’urbanistica, un elemento nuovo nella tradizione dei nostri comuni, che non conoscevano questo problema e che oggi esplode: i temi del governo del territorio chiamano le amministrazioni comunali ad un continuo esercizio di responsabilità, di soggettività politica. I servizi sociali, i servizi pubblici, la cui gestione era per l’innanzi soltanto un fatto virtuale, oggi costituiscono esercizio reale delle attività di governo a livello comunale. Siamo così in presenza di una democrazia partecipata, che va maturando e crescendo insieme ai vasti e complessi problemi della nostra comunità.
Si è nel contempo modificato lo Stato: lo Stato, da entità centralistica, è diventato regionale, ma non è diventato regionalista, il che non è senza significato.
La Costituzione ha definito il trapasso dallo Stato liberale-monarchico, fondato sulla centralizzazione e verticalizzazione dei poteri, allo Stato regionale. Ma in effetti il nostro Stato non è mai riuscito a diventare regionalista, perché centraliste sono rimaste le istituzioni ai vertici dello Stato; in particolare il Parlamento, che è disegnato sulla vecchia concezione dello Stato sabaudo, non ha avvertito il respiro dell’Europa e delle moderne società democratiche. Società che, tutelando ed esaltando le comunità storiche, organizzano l’esercizio reale dei poteri non secondo modelli verticistici, ma secondo modelli orizzontali, che coinvolgono il popolo e le grandi masse nelle decisioni e nella partecipazione alle scelte prioritarie della vita comunitaria nazionale.
Nel nostro Paese il regionalismo non è mai diventato tale. Le grandi scelte sono sempre rimaste riservate al vertice e si trasmettono alle istituzioni regionali perché le attuino, in una sorta di decentramento che non diventa autonomia, che ne tradisce anzi lo spirito e ne impedisce lo storico realizzarsi. Basterebbe leggere, in questi ultimi giorni, il disegno di legge sulla riforma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare il famigerato articolo 11, per capire quanto di involutivo, di sconvolgente arretramento possa prodursi nella civiltà giuridica del nostro paese, proprio laddove, a chi iniziava i suoi studi di giurisprudenza, un tempo si spiegava anzitutto che tra le fonti del diritto primeggiava, nel previgente ordinamento, lo Statuto albertino ed in quello attuale la Costituzione, quindi le leggi e al di sotto di esse i decreti ministeriali, o le circolari, di tal che la circolare non aveva mai alcuna possibilità di modificare o di prevaricare le leggi dello Stato.
Ebbene oggi, se la legge di riforma del Consiglio dei Ministri dovesse entrare in vigore nel testo proposto ed approvato dalla Camera dei Deputati e dalla prima Commissione del Senato, le circolari di indirizzo e di coordinamento del Presidente del Consiglio prevarrebbero sulle leggi e sulle stesse norme statutarie, perché in quel provvedimento il coordinamento governativo è considerato prevalente su qualunque altro valore giuridico-istituzionale.
L’Italia si avvia a un periodo di grandi incertezze costituzionali, di insicurezza sull’ordinamento e sui grandi principi che regolano la vita della comunità nazionale e delle diverse istituzioni nel rapporto tra loro, in particolare tra autonomie regionali e poteri centrali dello Stato. La stessa Corte costituzionale manifesta crescenti discontinuità giurisprudenziali, che l’hanno vista talvolta — raramente — volgersi verso interpretazioni regionalistiche, ma di recente, sempre più insistentemente, verso interpretazioni centraliste. Interpretazioni che denunciano peraltro la sua origine impropria e impura, quale giudice eletto da una parte, e di cui traspare uno spirito di parte che ne compromette il prestigio e la credibilità di giudice. Sono considerazioni che il Presidente della Regione, non più tardi di qualche giorno fa, esponeva al Presidente della Corte costituzionale, sentendosi rispondere che certo, altre Costituzioni concepiscono in modo ben diverso il costituirsi e i metodi di elezione delle Corti, le quali vengono, per quanto attiene ai conflitti tra poteri regionali e poteri centrali dello Stato, elette con parità di rappresentanti dalle regioni e dallo Stato. In tali ordinamenti solo il Capo dello Stato può nominare alcune personalità di grande prestigio per integrarle, onde consentire il superamento dei bracci di ferro tra i rappresentanti o giudici eletti dal potere regionale e quelli eletti dal potere centrale.
Direi che quello italiano è uno dei pochi casi al mondo di una Corte costituzionale eletta da uno solo dei poteri. Le stesse isole Faeròer, in Danimarca, hanno il diritto, nel caso di contrasti che insorgano tra le popolazioni di quelle isole e lo Stato centrale, di nominare tanti giudici quanti sono quelli eletti dal Parlamento e dal Governo danese.
Si è ormai aperto un ricco e fervido dibattito anche in ordine ai supremi organi legislativi, in particolare sulla necessità che essi ricomprendano la componente regionale della Repubblica in una Camera delle Regioni. Il Costituente, del resto, concepì il Senato quale Camera rappresentativa delle Regioni: fu il legislatore ordinario ad elaborare una legge elettorale che ha tradito questo ruolo, facendo della seconda Camera la copia niente affatto esaltante della prima. Oggi si discute sul ruolo da dare alla seconda Camera, considerata l’inutile perdita di tempo in cui attualmente si traduce il doppio esame delle leggi. Si discute dunque se sia più opportuno specializzare per materie le due Camere o costituire la seconda Camera in funzione di un’ottica regionale, che consenta di filtrare tutta la legislazione e le grandi scelte attraverso una valutazione che le Regioni, nella loro diversa sensibilità e struttura politica, possono offrire, ai fini di un riequilibrio, di una composizione e ricomposizione dei grandi interessi che fervono nella vita del paese.
Ma vi è un elemento nuovo, ancora, che arricchisce ulteriormente il nostro orizzonte politico: la Comunità Economica Europea. Anche in ordine a questo potere sovranazionale tuttavia occorre domandarsi: come si è atteggiato questo potere? Ecco il quesito che in questo momento storico ci dobbiamo porre: questa realtà sovranazionale è venuta configurandosi come un potere europeo o invece come un potere interstatuale, che, attraverso la composizione degli interessi del singoli stati — e quindi attraverso una trattativa tra i vertici degli stati — ha consentito l’emanazione e l’assunzione di provvedimenti tali anch’essi da comprimere ancor più i poteri regionali? In realtà la Comunità Economica Europea ha finito con l’atteggiarsi non come un potere unitario e collegiale dei popoli d’Europa, ma come un potere gestito dai vertici degli stati, incapaci di cedere anche una sola parte delle rispettive sovranità al potere sovranazionale europeo, quindi incapaci di creare una nuova democrazia europea. L’intento di conservare per intero le rispettive sovranità ha prodotto soltanto, attraverso trattati multilaterali, singole intese su singoli problemi, ed in tutto questo le Regioni sono rimaste estranee. Ecco come si è andato modificando il quadro della politica in questi anni, ecco quindi la questione decisiva: quella del ruolo che la Regione deve riuscire a costruirsi in un contesto radicalmente nuovo. Solo attraverso una nuova forma di autonomia la Regione riuscirà ad esprimere e a realizzare gli interessi veri e profondi della nostra comunità. Dobbiamo sfuggire cioè a questa strana apparente contraddizione della nuova realtà europea, di questo massimo di interrelazione coniugato col massimo della concentrazione dei poteri. E i nuovi valori che emergono sono in fondo quelli di sempre: prima di tutto questa domanda profonda di democrazia, ma di una democrazia rivissuta attraverso tutti i processi di crescita e di sviluppo di cui ho parlato nella mia introduzione. Oggi il concetto di democrazia passa attraverso il diritto al lavoro, altrimenti la parola democrazia risulta sufficientemente enfatica ma priva di reali contenuti; passa, sul piano regionale, non tanto attraverso la lettera, ma certamente attraverso i principi dell’articolo 13 dello Statuto, ed anzitutto quello della solidarietà reale della comunità nazionale nei confronti della comunità regionale, per superare lo squilibrio, grave e storico, che separa la nostra comunità dalla complessiva realtà del paese. Una solidarietà reale, effettiva, creativa, feconda, per cui le vibrazioni, non di uno Stato formalmente inteso, ma di uno Stato-comunità, di uno Stato-collettività, determinino il fiorire di una democrazia capace di produrre unità. Tra le rinnovate domande dell’autonomia vi è quella dell’identità culturale, come processo di riappropriazione dell’identità etnica di ogni popolo che vuole restare sé stesso, che non accetta né prevaricazione né estinzione, ma fa riemergere prorompente la propria soggettività culturale, etnica e quindi politica, perché il dialogo sia reale: non vi è dialogo, infatti, fra chi non esiste e chi invece, prevaricando gli altri, li estingue. Il dialogo è possibile solo fra pari dignità, fra pari titolarità e soggettività politiche. Ecco il nuovo concetto di democrazia: l’autonomia passa attraverso questi valori. Certo l’economia, lo sviluppo, sono processi importanti, ma al fondo sono i valori quelli che contano: il diritto al lavoro, la solidarietà, la collettività nazionale, la soggettività politica dei gruppi che compongono la comunità statuale. La Regione deve finalmente riuscire ad esprimere capacità reali nel concorrere alle grandi scelte della programmazione, nazionale ma anche europea. Questo è il ruolo della regione: che se questo non fosse basterebbe un prefetto, un ufficio bene organizzato, funzionari di prim’ordine (se ne trovano tanti); per avere invece soggetti politici chiamati ad essere l’espressione autentica, immediata di popolo, i poteri devono potersi esprimere nelle grandi scelte della vita nazionale ed europea. Altrimenti si è sudditi e non cittadini, destinatari di decisioni pensate all’esterno ed attuate poi nella periferia. Nessuno accetta più di essere periferia e suddito di decisioni centralistiche prese al vertice da poteri lontani e indifferenti, incapaci di cogliere i fermenti nuovi che rivitalizzano le società.
Noi dobbiamo anche cogliere, tuttavia — ed ecco l’altro aspetto della democrazia autonomista — la domanda diffusa di una comunità che nel suo insieme rivendica la massima partecipazione a quei poteri che la Regione non deve richiamare per sé, ma per le istituzioni della democrazia di base: occorre cioè ritrasferire questi poteri ai comuni, agli enti intermedi, alla democrazia così come questa si organizza nel territorio. In un nuovo rapporto tra cittadino e Regione, la Regione da istituzione e potere diventa ordinamento; questa è nella visione della Giunta, la prospettiva che si va realizzando attraverso lo studio della riforma, non solo dello Statuto, ma dell’ordinamento interno della nostra comunità. La Regione deve diventare garante dei diritti dei cittadini e deve diventarlo anzitutto nei confronti dei suoi stessi poteri, nel momento stesso in cui vuol essere rappresentativa dei cittadini rispetto ai poteri dello Stato. Una volta elaborata la riforma, così come la Giunta attraverso la mia modesta interpretazione ne sta proponendo a voi le linee, una volta definito, nella consapevolezza di questa Assemblea, il nuovo palinsesto dell’ordinamento regionale sia nei suoi rapporti con lo Stato, sia nei suoi rapporti con i cittadini e con gli enti sub-regionali, dovremmo dar vita alla Commissione paritetica. Non parlo della Commissione per l’attuazione dello Statuto, naturalmente: quello è un compito che stiamo assolvendo, un’attività che procede; abbiamo avuto modo anche nelle settimane scorse di definire alcuni importanti capitoli di questo lungo cammino dell’attuazione statutaria. Mi riferisco invece ad una Commissione paritetica di natura politica, fra i poteri dello Stato e i poteri regionali, per la riforma dello Statuto, in conformità con l’impegno assunto dal Capo del Governo nelle sue dichiarazioni rese all’atto dell’insediamento della legislatura in atto.
Occorre essere consapevoli che la Giunta sta affrontando in termini di estrema difficoltà i propri compiti e nondimeno sta assolvendoli in termini sufficientemente adeguati rispetto agli impegni programmatici assunti. Governiamo, come ieri è stato da più parti ricordato, una Regione che è invecchiata negli anni, che si è inaridita sul piano organizzativo, che continua a gestire procedure corpose, grevi, arrugginite, che opera attraverso una molteplicità di leggi superate e reciprocamente intrecciate, con un organico fatto si di dipendenti che si prodigano molto spesso al limite delle proprie energie fisiche ed intellettuali (con una generosità su cui la Giunta regionale non può che esprimere apprezzamento e gratitudine), ma che nondimeno denunzia grandi vuoti, vistose insufficienze. Vi sono Assessorati che non dispongono del personale strettamente indispensabile per gestire l’ordinario! Siamo in una fase di transizione e di ripensamento di tutta l’organizzazione, di tutta la struttura regionale; nondimeno io voglio ricordare le dichiarazioni di un uomo che non proviene da questi banchi, ma che, da un osservatorio di rilevanza nazionale, può esprimere giudizi sufficientemente affidabili e credibili, quale il Segretario generale della CGIL. La Conferenza nazionale della CGIL sui problemi del Mezzogiorno si tiene certo in Sardegna come atto di solidarietà verso la grande massa di lavoratori sardi che denunziano il più alto indice di disoccupazione: ma si tiene in Sardegna anche perché la nostra è la Regione che ha la più bassa percentuale di residui passivi, sia in correlato che in assoluto, il che significa che gli impiegati hanno fatto il loro dovere, e significa altresì che il potere politico regionale si è mobilitato, attivando con tutte le energie possibili gli strumenti di cui dispone. Debbo ricordare che nell’86 ci siamo trovati nella difficile condizione politico-istituzionale che va sotto il generico nome dei «regolamenti non registrati», e che questo ha bloccato per lungo tempo la spesa pubblica e ha certamente rallentato in modo grave e significativo la dinamica operativa dell’amministrazione regionale. Tuttavia non è guardando all’indietro che noi operiamo, ma guardando avanti: uno dei primi impegni che questa amministrazione ha assunto e che va traducendo in realtà — e tra qualche settimana il Consiglio regionale sarà chiamato ad esprimere le sue valutazioni — è la grande riforma che verrà introdotta attraverso l’adozione del piano triennale e del bilancio poliennale. Un modo nuovo di concepire e di gestire la programmazione nella nostra Regione; una programmazione a medio termine che dia certezza ai diritti, che dia punti di riferimento e capisaldi certi agli operatori economici, che consenta di esprimere valutazioni caratterizzate dal respiro degli anni e non dall’incalzare del precario, dell’insicuro, dell’incerto, così come oggi si fa e sino ad oggi si è fatto. Una programmazione che dia fluidità alla spesa pubblica, superando definitivamente l’antica cancrena dei residui passivi e dando certezza allo sviluppo, vissuto non solo in termini regionali ma nel contesto nazionale e nella prefigurazione della politica europea.
L’esecutivo regionale, cari colleghi, non sta dunque aspettando la riforma della Regione o la riforma dello Statuto, ma sta operando nel concreto, creando le condizioni perché le riforme si realizzino. Ed uno dei modi più attivi, più incisivi, più concreti di credere in questi principi è quello di trasferire le risorse finanziarie. Noi abbiamo trasferito nell’86 il 50 per cento della spesa manovrabile ai comuni, alle comunità locali; è la prima volta nella storia dell’autonomia regionale che un’operazione di questo genere è stata fatta: 600 miliardi sono stati trasferiti ai comuni nello scorso esercizio finanziario, e quest’anno, nel bilancio ’87, ne sono previsti 700.
E allora, amici cari, quando parliamo di decentramento di poteri, di deleghe, di trasferimenti, cominciamo a dire che questo non si realizza con le chiacchiere, ma dando strumenti operativi concreti agli enti locali perché programmino il loro sviluppo, perché realizzino le opere pubbliche, perché realizzino i servizi. La Regione sta rinunciando a gestire in proprio queste risorse e sta dando possibilità di programmazione effettiva alle istituzioni della democrazia di base.
Anche la legge sul CRAAI è certamente una legge di riforma, cari colleghi, ed è una legge già approvata, con la quale noi trasferiamo le funzioni di un ente la cui storia è presente alla memoria di tutto il Consiglio regionale, le cui pagine sono scritte nella cronaca ma anche nella coscienza politica dell’istituzione autonomistica. Ebbene: finisce questa esperienza e se ne prospetta una nuova, più democratica, più efficiente, organizzativamente più credibile perché gestita dalle province; è un decentramento che riguarda una massa di personale pari ad oltre 600 dipendenti: non una piccola cosa, ma una cosa importante nel quadro di riferimento della vita regionale.
Il disegno di legge sull’assistenza, cari colleghi: l’amministrazione regionale l’ha licenziato da oltre un anno, è all’esame del Consiglio ed io sono certo che il Consiglio sta riflettendo, meditando, soffrendo su questo importante tema, perché i destinatari della legge sull’assistenza non saranno i forti o i ricchi, ma i deboli della nostra comunità, quelli che hanno bisogno della sollecitudini del potere politico ed istituzionale. Certamente il Consiglio è consapevole di questo e ci restituirà questo provvedimento sviluppando le linee approvate dalla Giunta; ce lo restituirà migliorato, l’importante è che ce lo restituisca: in ogni caso la Giunta regionale questo importante disegno legislativo di civiltà e di riforma dei poteri, che articola nei comuni le capacità decisionali, organizzative e programmatorie in ordine all’assistenza, lo ha predisposto. Così come la nuova legge sui lavori pubblici, che dà ai comuni il potere istituzionale di organizzare le nuove strutture: la Giunta l’ha approvata, è all’esame del Consiglio, so che il Consiglio ha sentito ripetutamente l’Assessore, che il Consiglio ha reiteratamente pensato e ripensato questa legge per farne scaturire linee che diano luogo ad un raccordo corretto e costruttivo tra potere regionale di programmazione e di indirizzo e funzioni delle amministrazioni comunali. È comunque una larga fascia di potere quello che l’amministrazione regionale trasferisce ai comuni. Mi diceva un ministro dello Stato, appena qualche giorno fa, parlando di alcune leggi di riforma: «Ma tu, che vuoi? Certe leggi non si modificano mica tanto facilmente: il Parlamento è pieno di onorevoli eletti attraverso i lavori pubblici». Il governo delle grandi risorse crea meriti e legami con le opinioni pubbliche locali: bene, la Regione rinuncia ai consiglieri eletti attraverso le leggi sui lavori pubblici o attraverso gli stanziamenti per lavori pubblici. L’amministrazione regionale trasferisce ai comuni questi poteri: il Consiglio approvi la legge e la Giunta non avrà niente da rivendicare, perché si tratta di una proposta della Giunta.
Così come nel piano triennale voi troverete la proposta di una nuova legge per il decentramento dei poteri in materia di agricoltura. Una nuova legge in favore degli enti locali, perché le istruttorie siano fatte non più dalla amministrazione regionale, ma dagli enti locali attraverso gli organi tecnici che l’amministrazione regionale metterà a loro disposizione, perché le decisioni in materia di finanziamento dei miglioramenti fondiari siano prese dai comuni: istruttorie, decisioni e assistenza tecnica. II comune deve crescere, il comune deve diventare un centro reale di propulsione e di decisione di cultura dello sviluppo. Questo, nel piano triennale, il Consiglio regionale troverà come proposta della Giunta; ma troverà anche il disegno di legge sulle acque: un’altra grande conquista che dimostra come la Giunta stia operando in tutte le direzioni, con ricchezza di iniziativa e con ampiezza di visione. Vorrei dire a questo proposito — per quel tanto di discutere che si è scatenato anche da parte di politici che bene farebbero prima di parlare a informarsi, per avere e dare notizie certe che la Giunta non ha preso nessuna decisione definitiva circa il progetto delle acque. La Giunta si è limitata a prendere conoscenza di un’interessantissima proposta formulata da alcuni imprenditori sardi e da altri imprenditori non sardi, ma sarà ben lieta se a tale proposta ne seguiranno altre ed altre ancora, su questa come su altre materie. Prima che qualunque decisione venga assunta, in ogni caso, sentire proposte di questo genere per noi è motivo di soddisfazione: vuol dire che la Giunta regionale è ritenuta un soggetto affidabile, è ritenuta interlocutore capace di pensare in grande, di progettare, in termini innovativi e profondamente modificativi dell’esistente, questo bene supremo che è l’acqua. Un bene che deve essere al servizio della comunità e non come oggi, perduto e inutilizzato quando non nefasto e rovinoso, perché ancora non irregimentato né controllato e inalveato attraverso gli strumenti che proprio un piano delle acque, da realizzare nei prossimi anni, potrà predisporre.
Il fatto che la Giunta abbia delle idee o che le proponga, e che intorno a queste idee si accenda tanto interesse è un fatto positivo, che noi rivendichiamo ad onore della Giunta, invitando coloro i quali non sono informati, prima di allarmarsi, ad assumere le notizie del caso. Altrettanto dicasi per il disegno di legge sui parchi, che porrà finalmente ordine e darà finalmente prospettive al governo del territorio in uno dei suoi settori più qualificanti. Analogo discorso vale per l’attuazione del D.P.R. 348 in ordine a trasferimenti e deleghe agli enti locali per competenze di carattere economico ed operativo. Altrettanto può dirsi per le leggi che si sono rese necessarie allo scopo di dare attuazione alla riforma del controllo sugli atti degli enti locali; oggi non abbiamo un insieme di strutture che operano nel territorio e non solo nelle quattro province, ma nel Sulcis Iglesiente, nell’Ogliastra, nella Gallura. Abbiamo creato una istituzione regionale per dare coerenza e unità di indirizzi a materie che non possono consentire episodicità nelle decisioni: un insieme di norme, quindi, che camminano nello spirito della riforma, ma precedendo la riforma.
La Giunta non è rimasta dunque in un’attesa inerte, statica, meramente immersa nell’astratto o nella elaborazione intellettuale, ma ha sviluppato un impegno operativo, traducendolo creativamente nella realtà regionale. Ma la Regione non è rimasta ferma neppure in tema di ipotesi di modifiche statutarie; abbiamo costituito una apposita commissione di studio: naturalmente è libero il Consiglio regionale di pensare come meglio crede e di costituire una propria Commissione speciale, annullando la prima Commissione, perché evidentemente non si ritiene che questa possa offrire sufficienti capacità politiche o elaborative. Ciò tuttavia comporta anche il superamento di una precedente impostazione della Giunta Rojch, che aveva rivendicato alla Giunta il ruolo di proporre le modifiche statutarie e di ordinamento interno. Noi abbiamo recuperato quella iniziativa, nominando più o meno gli stessi studiosi che erano stati individuati dalla Giunta Rojch (ne sono stati omessi due: non ho capito bene perché, considerato fra l’altro che si tratta di persone che godono della più alta considerazione da parte di questa Giunta e che quindi potranno essere da noi interpellate e coinvolte). Abbiamo recuperato l’analoga iniziativa della stessa Giunta Rais, che aveva rivendicato all’esecutivo l’iniziativa della riforma, incaricando una Commissione, esattamente come ha fatto questa Giunta. Questa Giunta entro maggio produrrà le sue proposte: vedrà il Consiglio se riterrà necessario costituire anche un’altra Commissione che si attivi parallelamente o dopo le proposte della Giunta. Certo non so quanto potrà essere produttivo il fatto che nel frattempo si predisponga un progetto di legge, istitutivo di tale Commissione, che successivamente tale progetto venga approvato e superi il controllo governativo, che poi il Consiglio nomini la Commissione e che questa possa completare i suoi studi: nel frattempo comunque gli studi della Giunta saranno a disposizione del Consiglio. La Giunta non può che definire la decisione al Consiglio nella sua sovranità; tuttavia la Giunta deve sommessamente sottolineare questo: che le Giunte Rojch e Rais avevano rivendicato all’esecutivo questo diritto-dovere, che questa Giunta ha mantenuto fede a quell’impegno, ha rinnovato gli studi e li sta completando ed entro il mese di maggio li metterà a disposizione del Consiglio regionale. Dopodiché il Consiglio regionale valuterà se sia da recepire questo studio o se sia da modificare o se vi sia da farne un altro. Ma consentirete alla Giunta di fare ciò che era nel suo programma, ciò che era nelle dichiarazioni programmatiche approvate da questo Consiglio e ciò che rientra nei suoi doveri istituzionali. In questa ipotesi noi vediamo una Regione che deve preliminarmente arricchirsi di tutti i poteri già di fatto riconosciuti alle Regioni ordinarie e di quelli che saranno ulteriormente riconosciuti alle Regioni a statuto ordinario, le quali stanno rivendicando l’ampliamento delle disposizioni di cui all’articolo 117 della Costituzione. Esiste in proposito un emendamento al testo costituzionale, che ho avuto l’onore di proporre alla Conferenza dei Presidenti, col consenso delle altre Regioni a Statuto speciale e col consenso unanime degli altri Presidenti di Giunta. Devo dire, peraltro, che alcuni colleghi Presidenti di Giunte regionali del Nord Italia (si distingue tra questi, come capofila, il Presidente della Regione Lombardia) non capiscono, non colgono tutta la ricchezza della specialità di Regioni quali la Sardegna o il Friuli Venezia Giulia o l’Alto Adige, e sostengono che ogni Regione ha le sue peculiarità, per cui ogni Regione dovrebbe avere un suo peculiare Statuto. Noi non contestiamo tale esigenza: certo, fino a quando si configurerà una sfera di poteri regionali attribuiti omogeneamente a tutte le Regioni, noi non potremo che rivendicarla anche per la Sardegna, con in più l’arricchimento dovuto alle peculiarità che comunque distinguono e diversificano la Sardegna rispetto alle altre Regioni. Se tuttavia ogni Regione dovesse rivendicare ed ottenere per sé uno Statuto speciale, non v’è dubbio che di fatto ci troveremmo di fronte ad uno Stato federale: anche su questo niente da ridire, nessun problema. Dovremmo in tal caso fare un salto profondo e innovativo di carattere istituzionale, e su questo ognuno e ogni componente politica ha una sua opinione; io non mi permetto di far prevalere la mia, ma a parer mio questa si configurerebbe come una ipotesi di Stato federale, non come un’ipotesi di Stato regionalista. Resta il fatto che l’essenza della specialità statutaria non risiede in un privilegio attribuito alle Regioni a Statuto speciale, ma in una esigenza di riequilibrio del loro status giuridico rispetto alle Regioni a Statuto ordinario, perché la peculiarità che diversifica alcune Regioni rispetto alle altre abbisogna di strumenti giuridico-istituzionali che consentano il raggiungimento di condizioni reali di parità. L’insularità non è certamente un fatto di privilegio: forse non sarebbe neanche un danno, con un diverso Statuto di autonomia. Io credo che, con un diverso Statuto di autonomia, che garantisse una reale specialità autonomistica, la stessa insularità potrebbe rivelarsi una condizione addirittura vantaggiosa, per la nostra Regione, ed ecco perché dico che la Regione valuterebbe in termini positivi, in sede di modifica dello Statuto, l’abolizione dell’articolo 5, ricomprendendo invece tutte le materie ivi previste nelle attribuzioni contemplate dall’articolo 4. Non ha più significato l’articolo 5, non ha più una sua ragion d’essere, soprattutto nel rapporto comparativo con le Regioni a Statuto ordinario.
Credo inoltre che ben difficilmente potremmo ipotizzare un governo reale dell’economia senza disporre anche dei poteri fiscali di accertamento, di riscossione e di ripartizione; di un potere fiscale reale, anche impositivo, e non aggiuntivo, badate, ma sostitutivo, perché lo strumento fiscale è quello attraverso il quale si possono incentivare le attività economiche o possono essere scoraggiate quelle parassitarie e socialmente dannose. Pensiamo allo sviluppo turistico: se cessa di essere tale per diventare pura speculazione immobiliare diviene fatto parassitario, economicamente negativo; evidentemente una tale questione può essere difficilmente apprezzabile in Lombardia, ma in Sardegna questo problema esiste, è un fenomeno che dobbiamo governare con strumenti originali, nostri. Laddove esiste ormai la massima concentrazione industriale ed occupativa può anche darsi che non si pongano nuovi problemi di incentivi allo sviluppo, ma in Sardegna la situazione è del tutto differente ed evidentemente una diversa e specifica manovra dello strumento fiscale diventa per noi essenziale. In fondo, quando si parla di zona franca doganale — pur adoperando ancora un vocabolo che appartiene alla cultura del passato, che non tiene conto del nuovo Mercato comune europeo, e del fatto che esso ha praticamente polverizzato il ruolo e il significato delle barriere doganali — è Io strumento fiscale (nello specifico: la franchigia) che viene chiamato in causa. Leggete la relazione introduttiva al dibattito sui problemi meridionali, fatta dal relatore ufficiale della CGIL: tale relazione fa delle esenzioni fiscali uno strumento fondamentale per lo sviluppo del Sud. Praticamente la franchigia fiscale diventa strumento di governo, di sviluppo: quello che noi andiamo sostenendo da oltre dieci anni. La franchigia fiscale può e deve diventare un fatto statutario, se vogliamo governare realmente il nostro sviluppo, perché la Regione — è detto nello Statuto — ha una finanza propria. Che significa propria? Significa che ha un potere originario, non derivato; statutariamente tale potere nasce come diritto dell’istituzione regionale ad avere una sua finanza, quindi un suo accertamento ed una sua riscossione. In tal caso il rapporto con lo Stato si inverte: a noi, certo, corre l’obbligo di trasferire allo Stato una parte delle nostre risorse, come dovere di solidarietà nazionale; ma non si tratta più di un’erogazione dello Stato nei nostri confronti. È una visione che dà concretezza alla prospettiva autonomistica! Così come non è più accettabile — ed ecco perché dev’essere un potere nostro — che gran parte dei dipendenti di tutte le banche di tutte le aziende a partecipazione statale, di tutte le aziende private, che hanno sede sociale all’esterno ma operano in Sardegna, paghino le loro imposte fuori dalla Sardegna: questo potere di accertamento dev’essere nostro. Così come deve finire questo grande equivoco dell’imposta di fabbricazione, che viene riscossa al consumo, per cui si defrauda la Sardegna di cifre enormi. Sono poteri statutari che debbono essere ridefiniti, e debbono essere ridefiniti non in sede tecnica, ma in sede politica, attraverso il confronto tra Governo centrale e Governo della Regione. Io non ripeto l’espressione: «Confronto Stato-Regione»; mi sono sempre rifiutato di usare questa antinomia di fronte ai Ministri dello Stato e di fronte al Capo del Governo, perché la ritengo offensiva delle istituzioni quasi che la Regione sia un interlocutore dello Stato, quasi che la Regione sia una sorta di antitesi dello Stato. La Regione è Stato, perché lo Stato è popolo, e noi siamo il popolo dello Stato. La Regione è territorio e noi siamo il territorio dello Stato; la Regione è ordinamento, e noi siamo l’ordinamento dello Stato! Che significa che il Governo centrale riassume in sé tutti i poteri dello Stato? È una concezione burocratico-centralista, che identifica nei poteri centrali lo Stato e nei poteri locali una sudditanza che va disciplinata, contenuta in un rapporto che non ha nulla di paritario, che mantiene inalterata la sostanza di un centralismo duro a morire.
In questa visione l’articolo 13 deve cessare di avere il suo carattere di straordinarietà: deve diventare uno strumento operativo permanente sino a che non verrà superato lo sviluppo economico, sociale e civile tra la nostra Regione e le parti più avanzate del territorio. La stessa attuazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno non può essere più affidata al potere centrale, che di volta in volta stabilisce la ripartizione delle risorse. Eravamo riusciti a strappare un 11 e 6 per cento, mi pare: in effetti, poi, il Governo ce ne ha trasferito il 9,9 per cento. Questa continua lotta, questa continua zuffa non è più accettabile, non è compatibile con la certezza dei flussi finanziari, con la certezza della programmazione, con la dignità stessa delle istituzioni, che devono potersi muovere nel respiro e nel rispetto delle procedure. Altrimenti saremmo davvero all’assalto della diligenza, ad una concezione profondamente incivile, alla legge della giungla, per cui i più forti fanno bottino delle risorse dello Stato e ai più deboli restano soltanto le briciole. Dobbiamo parametrare anche le risorse dell’intervento straordinario, dare certezza di flussi e dare ai poteri regionali capacità di elaborazione reale, non riservare al potere centrale le decisioni: «Questo lo ammetto, questo non lo ammetto», per cui ciò che tale potere non ammette praticamente diventa mutilazione delle risorse, e di cose che non ammette, purtroppo, con le motivazioni più diverse, ce ne sono sempre tante.
Così come noi dobbiamo avere poteri reali sul demanio marittimo. Che significa che noi succediamo allo Stato in tutti i suoi beni meno che nel demanio marittimo? Perché? È territorio della Regione, è una proiezione economica della Regione. Noi abbiamo il governo della pesca, il controllo e la disciplina del patrimonio del corallo, perché non dobbiamo avere il governo del mare? Perché non dobbiamo avere il governo dell’economia marittima? Perché questa è la realtà: abbiamo 2000 anni di storia nel corso dei quali la Sardegna non ha mai avuto un’economia marittima e quindi è diventata mercato marginale, mercato residuale. Noi dobbiamo rivendicare un ruolo decisionale sui nostri collegamenti, perché altrimenti resteremo dei trasportati. Anche nei giorni scorsi, col Ministro per il Mezzogiorno discutevamo di questi temi. Che significa che voi decidete cosa ammettere al beneficio degli sconti del 30 per cento, tra l’altro del tutto insufficienti? Tutte le altre insularità d’Europa hanno integrazioni dello Stato di molto superiori. Se decidete, voi, di ammettere il cemento al beneficio del 30 per cento, nel giro di 10 giorni noi dobbiamo chiudere le cementerie della Sardegna, perché la tale impresa, che ha nome e cognome e che importa dalla Grecia a prezzi stracciati, può portarsi il suo cemento in Sardegna e far chiudere le nostre cementerie: così crolla un nostro settore industriale, che pure ha una sua ragion d’essere, e, una volta che quella tale impresa abbia conquistato il monopolio, avremo finito di poter costruire secondo valutazioni e principi di competitività.
Noi dobbiamo poter partecipare alle decisioni che riguardano il nostro collegamento col continente e i nostri rapporti economici con l’esterno. Non è più accettabile che il Governo possa sospendere in qualunque momento le leggi regionali, mentre le leggi dello Stato, anche se rovinose per la nostra economia, hanno applicazione immediata perché noi non abbiamo un potere reale di sospensione. Deve poter esistere una istituzione — sarà la Corte costituzionale, sarà una particolare Commissione del Parlamento — ci dev’essere pure un meccanismo attraverso il quale una legge dello Stato in casi particolari possa essere sospesa. Occorre poi estendere in modo più organico, permanente e diffuso, la partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei Ministri, ai comitati interministeriali, allo stesso CIPE, laddove si decidono questioni che in qualche modo interessano la nostra Amministrazione regionale. Così in materia di ordine pubblico: nello Statuto c’è una previsione, ma in concreto la Regione è del tutto priva di qualunque capacità di decidere. Certo, nello Statuto si dice che il Presidente della Regione può chiedere l’intervento delle forze armate: probabilmente era allora il modo prevalente di concepire la repressione dei disordini per tutelare la pace sociale. «Chiamare le forze armate»: forse si vuole fare riferimento alle forze di polizia, ma la verità è che in oltre cento anni di storia unitaria lo Stato non è riuscito a sradicare un certo tipo di criminalità in Sardegna, come non è riuscito a sradicare la mafia in Sicilia, non è riuscito a sradicare la ‘ndrangheta in Calabria, non è riuscito a sradicare la camorra nel Napoletano e in Campania, perché pretende, mantenendo una unica struttura delle forze di polizia, di ignorare le realtà e i problemi specifici attraverso i quali si forma il processo criminale.
Evidentemente vi sono processi culturali diversi che vanno affrontati — e prima ancora apprezzati e vissuti — in forme del tutto nuove e specifiche: non basta una piatta vocazione repressiva, che tra l’altro non favorisce certo alcun coinvolgimento delle popolazioni. Non si può dire che in Sardegna non vi sia una domanda di giustizia: essa è diffusa, profonda, vibrante, ma questo Stato non riesce ad esaudirla, neanche nell’attività giudiziaria. Lo Stato non riesce a sconfiggere una criminalità che in Sardegna, fra l’altro, non è organizzata, quindi sarebbe più facilmente aggredibile, più facilmente isolabile: in ogni paese la gente sa chi sono i criminali e come potrebbero essere isolati, però vive di paura, perché lo Stato non pare in grado di proteggere, di difendere il cittadino che osasse sfidare la violenza della malavita. Una malavita che è fatta di individui e non di fasce sociali o di gruppi tra loro organizzati. Ecco perché un diverso coinvolgimento dei poteri locali in questo ambito non può che giovare; nessuno vuole trasferire in Sardegna esperienze esterne, ma certo è che in larga parte del mondo, dalle contee alle aggregazioni comunali a quelle regionali o degli States, esistono questi poteri.
Credo di aver delineato una prospettiva coerente di realizzazione della specialità. La Giunta ha apprezzato molto i contributi che sono venuti dagli interventi pronunciati durante questo dibattito ed è disponibile a coordinare le proprie iniziative con quelle del Consiglio, pronta ad accettare le decisioni che il Consiglio vorrà assumere. Certo: la Giunta rivendica a sé il ruolo di proposta che si sta realizzando attraverso la definizione di un nuovo progetto di Statuto per i rapporti con lo Stato e di Statuto interno di autonomia. Oggi noi abbiamo vissuto questa giornata di riflessione e di prospettiva; dal voto che scaturirà in conclusione di questo dibattito all’ordine del giorno che ci accingiamo a votare verranno indirizzi e linee di comportamento. Ciò che va sottolineato è quanto io dicevo all’inizio e che mi piace ribadire in conclusione: l’elemento che emerge come patrimonio geloso ed irrinunciabile della collettività sarda è l’autonomia. Questo Consiglio è chiamato ad esaltarlo per restituirlo più forte, più prestigioso, più utile alla comunità dei sardi, perché lo Stato cresca più civile e più giusto.